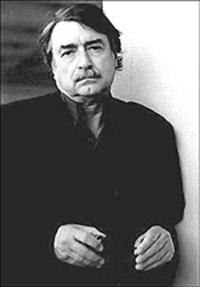Bertinotti ha toccato uno dei temi più delicati nel panorama politico nazionale: le televisioni di Berlusconi e di conseguenza il conflitto di interessi. In questi anni chi ha fatto lo stesso è stato etichettato la maggior parte delle volte come "liberticida" e quindi "comunista". Basta sfogliare le pagine dei giornali per scorgere queste due parole che si rincorrono senza sosta in riprova della natura "illiberale" degli "eredi del comunismo" (le parole virgolettate sono del Cavaliere). Molte dichiarazioni di "solidarietà" sono arrivate dal centrosinistra stesso per difendere Mediaset "un patrimonio per l' Italia, un' impresa strategica che deve poter affrontare serenamente il futuro in un quadro di regole certe e all' altezza di un paese europeo"(parole di D'Alema nel lontano '96). Inoltre Marco Rizzo (Pdci) intervistato da una giornalista di Studio Aperto è stato capace di dire che il ridimensionamento di Mediaset sostenuto dal segretario del Prc andrebbe contro gli interessi dei lavoratori.
Si potrebbe andare avanti così, elencando affermazioni stupide di gente altrettanto stupida, a riprova della miopia, forse voluta, della classe politica italiana. Ma non avrebbe senso. Ha senso invece ricordare la sentenza della Corte Costituzionale riguardo la legge Mammì del 7 dicembre '94: "Il legislatore è vincolato ad impedire la formazione di posizioni dominanti nell' emittenza privata e favorire il pluralismo delle voci nel settore televisivo, [...] nel senso che l' esistenza di un' emittenza pubblica non vale a bilanciare la posizione dominante di un soggetto privato. [...] Il legislatore [...] doveva contenere e gradualmente ridimensionare la concentrazione esistente e non già legittimarla stabilmente, non potendo esimersi dal considerare che la posizione dominante data dalla titolarità di 3 reti su 9 assegna un esorbitante vantaggio nella utilizzazione delle risorse e della raccolta pubblicitaria". Queste parole sono sacrosante e dovrebbero essere ricordate più spesso a chi leva gli scudi contro Bertinotti per difendere i "custodi" del pluralismo e della libertà. Norma Rangieri analizza lo status quo in maniera realista e critica:
Si fa la televisione per vendere la pubblicità, non si vende la pubblicità per pagare la televisione. E' la regola aurea del medium commerciale che, in virtù di un modello limpido di business, produce straordinari profitti. In Italia Mediaset ne è un esempio forte, imbattibile, al punto che il recente bilancio ha regalato agli azioni una cedola superlativa, la più alta degli ultimi anni.
La televisione dell'ex presidente del consiglio è una grande industria. Come del resto lo è quella, altrettanto florida, delle italianissime mine antiuomo. Mediaset è la più grande fabbrica di demagogia populista, i suoi palinsesti (telegiornali-megafono e reality) la sparano a cannonate, annullando ogni lume di cittadinanza. Eppure, chi accenna a sollevare qualche dubbio sulla pubblica utilità di questa grande azienda commerciale (quella televisiva), commette un grave, gravissimo peccato di leso pluralismo. Come se dagli schermi Mediaset uscisse ogni giorni il lievito necessario per il progresso del paese, anziché quel misto di propaganda politica e spot mascherati da programmi.
La ragione di una reazione tanto strumentale è sotto gli occhi di tutti: si va a sbattere contro una classe dirigente (di destra e di sinistra) legata al piccolo schermo da un cordone ombelicale che nessuno vuole tagliare. Di cui porta una grande responsabilità il lento declino del servizio pubblico. La sua assimilazione al principio che si fa televisione per vendere la pubblicità, lo ha reso così affine, indistinguibile dalla tv commerciale, che il progetto di restituirlo alla dignità di un modello europeo (inglese, spagnolo, francese, tedesco) viene immediatamente piegato a un'idea di ridimensionamento educational, allontanando così l'idea di una sua rifondazione. Il minculpop c'è ora, con il soffocante cappio del controllo partitico che impedisce ogni riforma del mostro a sei teste. Invece di sbloccare il duopolio-monopolio, esso viene perpetuato con nuove leggi (da ultimo la Gasparri) che puntualmente fotografano l'esistente, rinviando ogni liberalizzazione del settore.
Se Fausto Bertinotti interviene sulla necessità di rompere il monopolio privato (senza neppure eccepire sulla utilità della merce), diventa il vendicativo manovratore, l'avanguardia di una ritorsione politica, il tagliatore di posti di lavoro. Parallelamente, di fronte al bisogno di privilegiare il servizio pubblico, si grida al dirigismo sovietico. Come se pubblico e partitico fossero il futuro. E allora si ripiega sulla piccola riforma: togliere una rete alla Rai e una a Mediaset (ipotesi suggerita dal bulimico regime di sei reti nazionali) che diventa l'unica grande riforma possibile. Un escamotage per ridisegnare la lottizzazione allargandone i confini a qualche eclave con il suo territorio già picchettato. Ma anche solo accennare a questa redistribuzione della torta, fa rizzare i capelli in testa al comunista Rizzo.
E si capisce, a ogni epoca le sue classi dirigenti. La esiziale commistione tra televisione e politica, che tuttavia, negli anni bernabeiani, configurava una industria culturale fatta dalle élite, via via è degenerata in un'industria senza eccellenza, con una mano d'opera (gli autori) rappresentata da un marketing (commerciale e politico) periferico, residuale.
Si potrebbe andare avanti così, elencando affermazioni stupide di gente altrettanto stupida, a riprova della miopia, forse voluta, della classe politica italiana. Ma non avrebbe senso. Ha senso invece ricordare la sentenza della Corte Costituzionale riguardo la legge Mammì del 7 dicembre '94: "Il legislatore è vincolato ad impedire la formazione di posizioni dominanti nell' emittenza privata e favorire il pluralismo delle voci nel settore televisivo, [...] nel senso che l' esistenza di un' emittenza pubblica non vale a bilanciare la posizione dominante di un soggetto privato. [...] Il legislatore [...] doveva contenere e gradualmente ridimensionare la concentrazione esistente e non già legittimarla stabilmente, non potendo esimersi dal considerare che la posizione dominante data dalla titolarità di 3 reti su 9 assegna un esorbitante vantaggio nella utilizzazione delle risorse e della raccolta pubblicitaria". Queste parole sono sacrosante e dovrebbero essere ricordate più spesso a chi leva gli scudi contro Bertinotti per difendere i "custodi" del pluralismo e della libertà. Norma Rangieri analizza lo status quo in maniera realista e critica:
Si fa la televisione per vendere la pubblicità, non si vende la pubblicità per pagare la televisione. E' la regola aurea del medium commerciale che, in virtù di un modello limpido di business, produce straordinari profitti. In Italia Mediaset ne è un esempio forte, imbattibile, al punto che il recente bilancio ha regalato agli azioni una cedola superlativa, la più alta degli ultimi anni.
La televisione dell'ex presidente del consiglio è una grande industria. Come del resto lo è quella, altrettanto florida, delle italianissime mine antiuomo. Mediaset è la più grande fabbrica di demagogia populista, i suoi palinsesti (telegiornali-megafono e reality) la sparano a cannonate, annullando ogni lume di cittadinanza. Eppure, chi accenna a sollevare qualche dubbio sulla pubblica utilità di questa grande azienda commerciale (quella televisiva), commette un grave, gravissimo peccato di leso pluralismo. Come se dagli schermi Mediaset uscisse ogni giorni il lievito necessario per il progresso del paese, anziché quel misto di propaganda politica e spot mascherati da programmi.
La ragione di una reazione tanto strumentale è sotto gli occhi di tutti: si va a sbattere contro una classe dirigente (di destra e di sinistra) legata al piccolo schermo da un cordone ombelicale che nessuno vuole tagliare. Di cui porta una grande responsabilità il lento declino del servizio pubblico. La sua assimilazione al principio che si fa televisione per vendere la pubblicità, lo ha reso così affine, indistinguibile dalla tv commerciale, che il progetto di restituirlo alla dignità di un modello europeo (inglese, spagnolo, francese, tedesco) viene immediatamente piegato a un'idea di ridimensionamento educational, allontanando così l'idea di una sua rifondazione. Il minculpop c'è ora, con il soffocante cappio del controllo partitico che impedisce ogni riforma del mostro a sei teste. Invece di sbloccare il duopolio-monopolio, esso viene perpetuato con nuove leggi (da ultimo la Gasparri) che puntualmente fotografano l'esistente, rinviando ogni liberalizzazione del settore.
Se Fausto Bertinotti interviene sulla necessità di rompere il monopolio privato (senza neppure eccepire sulla utilità della merce), diventa il vendicativo manovratore, l'avanguardia di una ritorsione politica, il tagliatore di posti di lavoro. Parallelamente, di fronte al bisogno di privilegiare il servizio pubblico, si grida al dirigismo sovietico. Come se pubblico e partitico fossero il futuro. E allora si ripiega sulla piccola riforma: togliere una rete alla Rai e una a Mediaset (ipotesi suggerita dal bulimico regime di sei reti nazionali) che diventa l'unica grande riforma possibile. Un escamotage per ridisegnare la lottizzazione allargandone i confini a qualche eclave con il suo territorio già picchettato. Ma anche solo accennare a questa redistribuzione della torta, fa rizzare i capelli in testa al comunista Rizzo.
E si capisce, a ogni epoca le sue classi dirigenti. La esiziale commistione tra televisione e politica, che tuttavia, negli anni bernabeiani, configurava una industria culturale fatta dalle élite, via via è degenerata in un'industria senza eccellenza, con una mano d'opera (gli autori) rappresentata da un marketing (commerciale e politico) periferico, residuale.